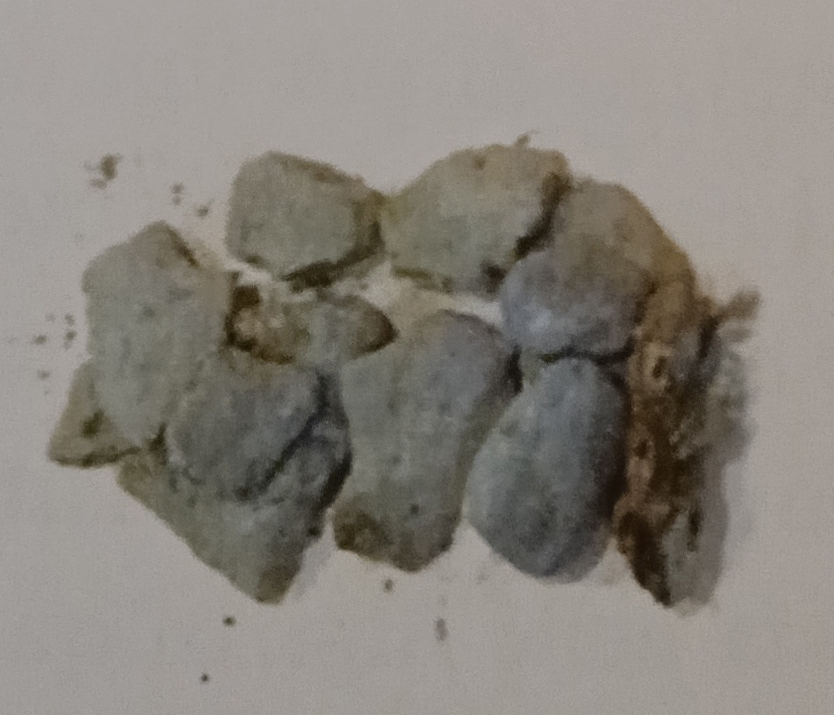I colori e gli strumenti dei “pictores” Pompeiani
Abbiamo già visto in passato quali fossero i pigmenti più comuni nelle decorazioni d’interni e di facciata fin dal Basso Medioevo, dedicando anche alcuni approfondimenti specifici a due di essi: il verdigris o verderame, descritto da Cennino Cennini e tipico soprattutto delle miniature su carta e dei dipinti a tempera su pergamena, e la calce blu o “poltiglia bordolese”, molto diffusa nell’edilizia urbana e rurale soprattutto nel XVIII e XIX secolo.
Ma che dire dell’architettura Romana, nella quale il colore aveva un ruolo fondamentale e gli affreschi (o gli stucchi policromi) rivestivano ogni superficie interna e talvolta anche esterna?
Per fortuna, possediamo una serie di testimonianze molto precise, sia letterarie (soprattutto grazie alla Naturalis Historia di Plinio il Vecchio e al De Architectura di Marco Vitruvio Pollione) sia archeologiche, costituite dai ritrovamenti diretti provenienti soprattutto da Pompei.
Mancano invece totalmente i documenti come ricevute di pagamento, inventari, diari di cantiere, bolle di spedizioni e contratti tra pittori e committenti che invece sono sopravvissuti sporadicamente per gli edifici medievali o rinascimentali.
In questo post desidero perciò approfondire l’argomento sui pigmenti utilizzati dai decoratori Romani, in particolare descrivendo due ritrovamenti decisamente significativi, e gli interessantissimi reperti esposti fino al 19 marzo 2023 presso il Museo Archeologico di Bologna nell’ambito della splendida mostra “I Pittori di Pompei”.
La taberna di S. Omobono
Nel 1974, durante gli scavi archeologi nell’area sacra di S. Omobono nel Foro Boario (ubicata a Roma tra il Campidoglio e il Velabro), si rinvennero i resti di della bottega di un fabbricante e/o venditore di colori, come farebbero supporre i numerosissimi grumi di pigmenti grezzi – pronti per la vendita ma non ancora mescolati con altre sostanze come cera o leganti organici (indispensabili rispettivamente nella pittura a encausto e tempera) – rinvenuti in una taberna (bottega) databile probabilmente al III secolo d.C.
Siamo quindi in un periodo posteriore di almeno 100-150 anni rispetto all’eruzione di Pompei, ma è del tutto naturale supporre che i pigmenti utilizzati fossero gli stessi, come effettivamente è emerso sia dalla testimonianza di Plinio il Vecchio, sia dai ritrovamenti descritti nei paragrafi seguenti.
I pigmenti ritrovati nella taberna di S. Omobono sono:
– Due varietà di ocra rossa del tipo sinopis: in altre parole, sinopia (Foto 1). Secondo Plinio esistevano tre diverse varietà di sinopia, e due di esse, chiamare rispettivamente cicerculum e pressior, avevano un prezzo al dettaglio di 8 assi.
– Due diverse varietà di ocra gialla, una più scura (praticamente arancione – Foto 2) e una più chiara, color giallo vivo (Foto 3). Plinio nei suoi scritti ricorda vari tipi di ocra gialla, come ad esempio il marmorosum utilizzato per dipingere ampie superfici: in effetti, negli edifici di Pompei ed Ercolano sono stati rinvenuti numerosi affreschi a sfondo giallo, che il calore dei flussi piroclastici dell’eruzione ha talvolta parzialmente trasformato in rosso (Foto 4). È interessante notare che anche Cennino nel Libro dell’Arte menziona due diverse varietà di “ocria“, chiamate genericamente “chiara” e “scura”.
– Due diverse varietà di terra verde (Foto 5), rispettivamente a base di glauconite e celadonite. Si tratta di due pigmenti quasi identici, comunissimi anche nel Medioevo – ad esempio per l’esecuzione delle finte tappezzerie tipiche della decorazione interna degli edifici – in quanto decisamente più economiche della malachite e – a differenza di questa – applicabili anche ad affresco: Cennino Cennini li definisce genericamente verdeterra e ne descrive chiaramente origine, usi e metodo di preparazione. I pittori romani li utilizzavano sia separatamente, sia mescolati in proporzioni ben precise.
– Vari tipi di blu egiziano (Foto 6): per maggiori approfondimenti su questo pigmento si rimanda ai paragrafi successivi.
– La terra bruna (Foto 7), che curiosamente Cennino non menziona nel proprio trattatello.
– Il nero (Foto 8), probabilmente costituito da polvere di carbone vegetale o proveniente da ossa calcinate, ma i Romani conoscevano e utilizzavano anche le terre nere (già menzionate da Cennino).
Nota – Le foto e le informazione di questo paragrafo sono tratte dal saggio Uso dei colori e scelta dei pigmenti nel mondo romano di Monica Ceci e Hilary Becker, in La pittura vesuviana. Una rilettura. Picta fragmenta, a cura di Paolo Giulierini, Antonella Coralini e Valeria Sampaolo, Silvana Editoriale, 2020.
Il dipinto della Foto 4 è un “paesaggio idillico sacrale” a sfondo giallo (con un’evidentissima alterazione cromatica parziale dovuta al calore dei flussi piroclastici dell’eruzione) distaccata da un’ala dell’atrio della Villa dei Papiri di Ercolano, esposto alla mostra “I pittori di Pompei” presso il Museo Archeologico di Bologna.
I colori dell’Insula dei Casti Amanti
Il secondo ritrovamento è avvenuto a Pompei, in una domus del complesso attualmente noto come “Insula dei Casti Amanti“, dal soggetto di un quadretto mitologico dipinto su una parete in IV stile, che rappresenta appunto due innamorati in un atteggiamento composto e dignitoso.
Qui, il 24 ottobre del 79 d.C. – gli storici e gli archeologi hanno infatti appurato che l’eruzione avvenne molto probabilmente a fine ottobre, e non in agosto come si riteneva in precedenza – una squadra di frescanti era al lavoro per rifare la decorazione di una stanza: una parete in particolare (Foto 9) era già stata completata (con la sola eccezione dello zoccolo, sempre dipinto per ultimo) con affreschi in quarto stile, che comprendevano alcuni pannelli laterali con architetture fantastiche (Foto 11) e una scena storica o mitologica al centro della composizione.
In particolare, il maestro della bottega (il pictor imaginarius, un pittore appunto specializzato in scene figurative) aveva già completato la sinopia con dell’ocra gialla (si notano molto bene alcuni personaggi con vesti drappeggiate – Foto 10) e aveva appena cominciato l’affresco vero e proprio dipingendo il cielo dall’alto verso il basso quando – probabilmente verso l’una del pomeriggio – iniziò l’eruzione. Buttò una scodella di calcina sopra al dipinto per mantenere fresco l’intonaco e completare il lavoro una volta terminata l’eruzione: non aveva compreso la gravità della situazione e ovviamente non tornò.
Naturalmente, nella fuga i pittori abbandonarono tutti i propri strumenti di lavoro, compresi i vasetti con i pigmenti ritrovati intatti dagli archeologici quasi 2000 dopo (Foto 14). Li ha mostrati molto bene Alberto Angela durante lo speciale rai “Stanotte a Pompei“, da cui ho tratto le foto della gallery: nonostante i colori si siano ovviamente seccati, si riconoscono perfettamente il bianco (probabilmente biacca, chiamata anche cerussa o cerussite e utilizzata nella preparazione del fondotinta utilizzato dalle matrone – Foto 15), il giallo (probabilmente ocra), il rosso (ematite – Foto 16), il verde (malachite, a giudicare dal suo colore scuro – Foto 17), l’azzurro (blu egizio, di cui parleremo anche nel prossimo paragrafo – Foto 18) e il nero (molto probabilmente polvere di carbone di ossa animali macinate, molto simile al “nero d’avorio” descritto da Cennino Cennini alla fine del XIV secolo). La cosa stupefacente – e anche commovente – è osservare, ancora perfettamente riconoscibili dopo quasi 2000 anni e un’eruzione disastrosa, le macchie sull’orlo dei contenitori, lì dove il pittore ripulì il pennello dall’eccesso di colore…
I reperti della mostra “I Pittori di Pompei“
Ma non si tratta degli unici pigmenti intatti scoperti a Pompei, Ercolano e Stabia. Nella già ricordata mostra “I pittori di Pompei“, di cui consiglio caldamente la visita, sono infatti esposti ben sei campioni di pigmenti, insieme ad altri strumenti di lavoro tipici di frescanti, stucchinai (decoratori specializzati nell’esecuzione degli stucchi), muratori, scultori, scalpellini e naturalmente architetti e agrimensori: tre pesi per fili a piombo, uno dei quali splendidamente decorato con una serie di modanature concentriche – Foto 19), una squadra da muro o un archipendolo (lo strumento era utilizzabile infatti con entrambe le modalità – Foto 20) e tre compassi da muro e/o cartografia, facilmente riconoscibili per avere entrambe le punte accuminate (Foto 21).
La loro forma è perfettamente identica agli strumenti odierni, e il loro uso era assolutamente necessario per l’esecuzione di misure e rilievi architettonici, o per dividere la parete da decorare, tracciare le linee guida e riportare il disegno con il metodo della quadrettatura, di cui abbiamo precisi riscontri archeologici: lo scarso spazio a disposizione mi impedisce purtroppo di approfondire l’argomento, sul quale esiste comunque una nutrita bibliografia.
I pigmenti esposti, corredati da pannelli esplicativi che qui riporto integralmente, sono invece:
Due campioni di ocra rossa e uno di ocra gialla – Sono qui esposte due ocra rosse (Foto 22) e una ocra gialla (Foto 22). A seconda della varietà, le ocra rosse e gialle potevano essere acquistate ad un prezzo variabile da 6 a 32 assi per libbra ed erano tra i colori più economici e disponibili [esattamente come succederà circa un millennio dopo per le decorazioni d’interni e di facciata medievali e rinascimentali – ndr]. Per fare un confronto, in questo stesso periodo, un soldato romano guadagnava circa 10 assi al giorno, e circa mezzo litro di vino, corrispondente ad un sextarius, veniva venduto ad Ercolano ad un prezzo che variava da 2 a 4,5 assi.
Blu egiziano (Foto 23) – Il blu egiziano, caeruleum Aegyptium, era un pigmento artificiale di silicato di rame e calcio e uno dei colori più costosi. La maggior parte dei tipi di blu egiziano venivano venditi a 128-176 assi per libbra. Esisteva poi una varietà più economica di blu egiziano, nota come tritum, che costava solo cinque assi per libbra; era probabilmente ricavato dagli avanzi macinati del più prezioso blu egiziano ed era molto diffuso nelle decorazioni.
Cinabro, robbia e un pigmento rosso porpora non identificato – Esistevano poi molti atri pigmenti costosi, come il cinabro rosso arancio (solfuro di mercurio, minium), che poteva essere venduto per non più di 280 assi. Il pigmento rosa qui esposto (Foto 24) era costituito da robbia selvatica tinta su un substrato argilloso. Non è stato possibile individuare con certezza il color porpora (purpurissum), ottenuto dal murice, mollusco della famiglia delle lumache di mare, sia stato utilizzato anche come colorante per produrre questo pigmento. Il pigmento porpora (Foto 25) è stato solo parzialmente analizzato; sappiamo che è fatto in parte di blu egiziano, mescolato con un porpora indeterminato [anche nel medioevo il viola veniva ricavato mescolando un pigmento blu a uno rosso: Cennino Cennino fornisce ben due ricette di questo tipo nel suo trattatello – ndr]. Il purpurissum era uno dei colori più preziosi e poteva costare da 16 a 480 assi per libbra. Non sappiamo quanto costasse, al tempo di Plinio, un pigmento a base di robbia selvatica (Rubia peregrina) o un mix tra robbia e porpora di murice. Nell’Editto dei prezzi di Diocleziano (301 d.C.) troviamo che i coloranti porpora e rosso scuro a base di kermes o licheni avevano un costo per libbra notevolmente inferiore alla porpora ricavata dal murice.
Poiché tutti i pigmenti su menzionati, e in particolare il cinabro e la robbia (largamente utilizzati anche nella pittura medievale e rinascimentale e citati da Cennino Cennini ne Il Libro dell’Arte), non sono adatti alla pittura ad affresco, è possibile che venissero utilizzati unicamente per l’esecuzione delle parti a tempera dei dipinti parietali, spesso – come si nota molto bene esaminando con attenzione molti dei reperti esposti – corrispondenti anche a interi quadretti o pannelli con ritratti, paesaggi, nature morte o scene mitologiche, o per l’esecuzione di dipinti su tavola a tempera o encausto, di cui possediamo sia precise testimonianze iconografiche (Foto 26, 27 e 28) che archeologiche, costituite in particolare dall’impressionante collezione dei ritratti del Fayyum.
Bigliografia
Per maggiori approfondimenti sui pigmenti degli antichi Romani, gli stili di decorazione e le tecniche di esecuzione si consigliano:
– Davvero! La Pompei di fine ‘800 nella pittura di Luigi Bazzani, a cura di Daniela Scagliarini, Antonella Coralini e Riccardo Helg, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 2013
– La pittura vesuviana. Una rilettura. Picta fragmenta, a cura di Paolo Giulierini, Antonella Coralini e Valeria Sampaolo, Silvana Editoriale, 2020. In particolare il saggio Uso dei colori e scelta dei pigmenti nel mondo romano di Monica Ceci e Hilary Becker, che descrive nel dettaglio il ritrovamento di Sant’Omobono.
Salvo diversa indicazione, tutte le foto sono state da me scattate nell’Insula dei Casti Amanti o durante la mostra “I pittori di Pompei”.